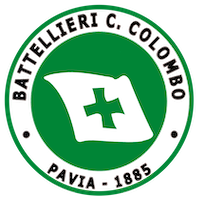STORIA DELLA BATTELLIERI CRISTOFORO COLOMBO
Dal 1887 una storia che merita di essere conosciuta.
LA CITTÀ E IL SUO FIUME
Il canottaggio è uno sport antico, quasi quanto la capacità dell’uomo di percorrere un corso d’acqua o sovrastare le onde del mare con un mezzo azionato dalla sola forza delle proprie braccia.
Il mistero avvolge anche le origini remiere pavesi nate, si presume, per necessità di sopravvivenza più che per semplice diletto. Pavia, è fuor di dubbio, ama il suo fiume, fino a definirlo “il più bello d’Italia”, ma è sempre stato così? Quando la città era circondata dalle vecchie mura spagnole, il Ticino doveva essere una presenza un po’ aliena ai rapporti amichevoli, spesso solo un’utile via per trasportare i prodotti agricoli e più in generale per gli scambi commerciali, seppure meta di qualche passeggiata serale, fonte di energia, necessaria a muovere le pale delle barche-mulino e habitat di gustosi pesci. Ma l’amore è un’altra cosa! Fu forse dopo il 1881, con l’annessione al Comune del territorio dei Corpi Santi, comprendente la zona della stazione ferroviaria, del cimitero, dell’Orto Botanico ma soprattutto, la foce del Naviglio e il Borgo Ticino che la città, arricchendosi di nuove terre poté contemporaneamente assorbire anche l’affetto dei suoi abitanti per il fiume.
Il Borgo vive infatti quotidianamente sul Ticino, per esso e grazie ad esso, quasi riceve in casa la sua acqua come se si trattasse di un ospite di riguardo, riconosce i suoi odori e umori, in un “rapporto intimo di orgogliosa parentela”, come sottolineò argutamente Augusto Vivanti.
Sulla riva sinistra solo i quartieri bassi di Porta Salara, Porta Nuova, Porta Calcinara partecipavano così assiduamente alla vita del fiume, accomunati ai borghigiani dall’umile esistenza.
Le lavandaie, i “giarö” e i “barchirö”, che la traduzione in lingua, certo non precisa come i termini in vernacolo, vuole cavatori di ghiaia e barcaioli, traghettatori di cose e persone, erano i frequentatori abituali delle sponde, risuonanti delle loro grida, parole e canti. Gente umile che praticava un lavoro faticoso con poche soddisfazioni.
La riva destra tutta e la parte della sinistra a monte del Ponte Coperto, dove la sponda è più dolce, erano affollate dalle lavandaie, una addossata all’altra eppure troppo intente al lavoro per perdere molto tempo a parlare, ma non a cantare, intenditrici d’opera e talune interpreti come coriste al Fraschini, o a rispondere con motti arguti alle provocazioni che rimbalzavano da una riva all’altra del Ticino, spesso originate dagli studenti in vena di goliardici scherzi. Con i mucchi di panni sporchi da una parte e lunghe file di biancheria stesa ad asciugare dall’altra, sembravano un tutt’uno con il fiume; nelle grandi caldaie l’acqua era riscaldata con la legna che le stesse lavandaie, con l’aiuto degli uomini di casa, procuravano nei boschi facenti da corona al letto del fiume. Sui “barcè” dall’alto scalmo, risalivano decise la corrente, scendevano a terra a far legna, caricavano la traballante barca e giù, verso la città a lavare panni. Per queste donne, abituate a trasportare sul fiume pesanti carichi, le gare inserite talvolta nel programma delle regate pavesi o in quelle tra barcaioli, con la barca vuota era uno scherzo, una passeggiata. Non così la pensavano i borghesi pavesi che accorrevano numerosi per vederle gareggiare, quasi alla pari cogli uomini. A ricordo incancellabile di questo mondo ormai antico ma pur sempre suggestivo e particolare è posto, a fianco del Ponte Coperto, naturalmente in Borgo, il monumento alla lavandaia intenta al proprio lavoro, opera di Giovanni Scapolla.
Evidente emerge l’utilità del “barcé”, barca dal fondo piatto, scorrevole sull’acqua, dalla vogata fatta stando in piedi, di cui è ricca la tradizione pavese, elemento essenziale all’umile economia dei fiumaioli.
Versioni ingrossate del “barcé” erano i “mutaiö”, il “saran” e la “nav” in ordine di grandezza, barconi impiegati per trasportare la sabbia e la ghiaia. Erano tutti lunghi oltre dieci metri, molto stabili adatti a trasportare grossi carichi, fino ai mille quintali della “nav”. Ad eccezione del “mutaiö”, usato come il “barcé”, erano muniti di grosso timone e avevano una piccola casupola a forma semi cilindrica a prua; lo strumento essenziale era però un attrezzo in legno a forma di cucchiaio che serviva per recuperare il materiale sul fondo del fiume. Secondo Gianni Brera, pavese di San Zenone Po, un equipaggio formato esclusivamente di “gerö” debitamente allenato non avrebbe uguali nella vogata alla “veneziana”. Ma i vecchi borghigiani, figli di cavatori e loro stessi del mestiere in gioventù, sostengono che i “giarö”erano troppo forti di braccia, dal fisico sproporzionato e rovinato dal duro lavoro per essere veri vogatori. Erano infatti troppo abituati a cerare, sollevare dal fondo del fiume, caricare, riportare a riva sabbia e ghiaia e poco a remare per non considerarlo, quando il fisico distrutto dalla fatica lo permetteva, un divertimento che trascendeva la passione.
I “barchirö”, invece, nati remando, furono ottimi vogatori di veneta, avvezzi com’erano al precario equilibrio abbinato alla velocità di chi sta perennemente in barca. Alcune voci, naturalmente mai provate ma con una radice storico-economica, sostengono che la destrezza e l’abilità pavese sul fiume derivi dal bracconaggio, essendo la velocità unica arma per sfuggire a eventuali arresti. Su e giù per il Ticino tutto il giorno, simbiosi totale tra l’uomo e il fiume, ma anche allenamento quotidiano: nei giorni di festa, invece di riposarsi, i più bravi gareggiavano usando le loro imbarcazioni ‘da lavoro’ e gli altri passavano il tempo ad incitarli. Ma le barche a Pavia non servivano solo per trasportare cose o persone; in una città dove i bambini prendevano confidenza con il remo in tenera età, si andava in barca a pescare nelle tranquille lanche o sulle sponde o a portare in salvo gli abitanti delle zone basse durante le inondazioni.
Era questa la vita sul fiume in una epoca in cui lo sport era fondato su basi elitarie, eccetto quelle discipline da sempre considerate ‘povere’, per la cui pratica non abbisognano di alcun investimento preventivo o d’esercizio, come il nuoto, il podismo, il ciclismo, grazie alla bicicletta contemporaneamente mezzo di trasporto o il canottaggio con la barca mezzo di sostentamento e anche di piacere per portare a spasso la “morosa”.
La tradizione vuole che il canottaggio agonistico sia nato proprio con una gara tra barcaioli a Londra nel 1716; ma ben presto fu praticato da nobili, borghesi e studenti, tutti propensi però a non stancarsi più del necessario, fatte le dovute eccezioni, piegati sui remi. Naturalmente a questo punto l’inserimento dei barcaioli nelle società remiere, necessario per completare gli armi e dare il tocco in più di forza e destrezza. Oltre un secolo dopo nascono nell’Italia unificata dal Risorgimento le prime società: nel 1861 a Pisa la “Canottieri Limite”, nel ’63 la “Cerea” e nel ’69 l”Armida” a Torino. A Pavia nel ’73 vede la luce la “Canottieri Ticino”, dall’impostazione aristocratico-borghese, ma sono proprio i barcaioli a gareggiare e a ben figurare. La “Ticino” accentra gli interessi dei pavesi per dodici anni, fino a quando un gruppo di soci dissidenti decide di fondare una propria società, la “Battellieri Cristoforo Colombo”. Da questo momento Pavia sportiva e fiumarola è divisa in ‘ticiniani’ contro ‘colombiani’.